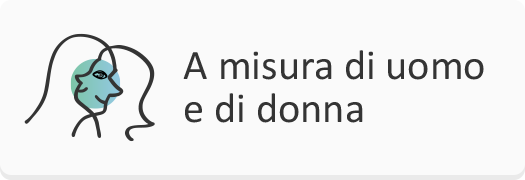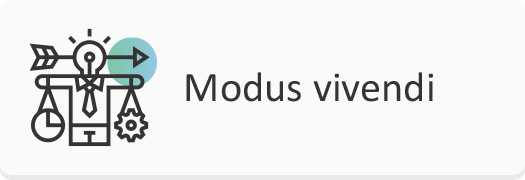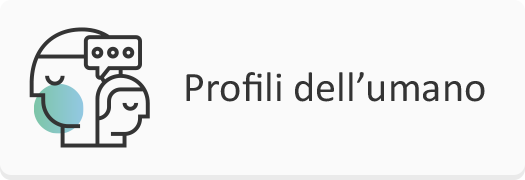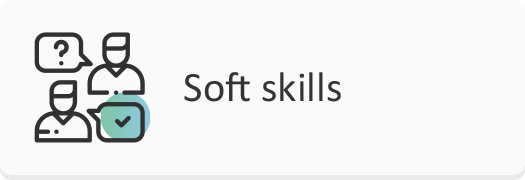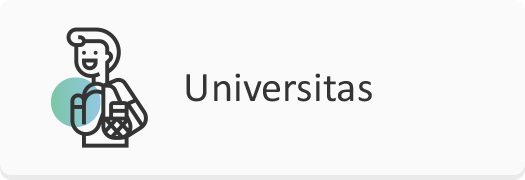di Stefano Graziosi

Le elezioni di metà mandato dello scorso 8 novembre si sono concluse con una situazione in chiaroscuro per entrambi i partiti. Nonostante abbiano conseguito dei risultati significativamente al di sotto delle aspettative, i repubblicani sono riusciti a conquistare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti. Dall’altra parte, indipendentemente dagli esiti del ballottaggio in Georgia previsto per il prossimo 6 dicembre, i democratici si sono rivelati in grado di mantenere il controllo del Senato. Ne consegue che il Congresso è fondamentalmente spaccato e che nessuno dei due schieramenti può realmente cantare vittoria.
Con la Camera a maggioranza repubblicana, Joe Biden si avvia ad essere la proverbiale “anatra zoppa”: il presidente può decidere se andare allo scontro a suon di veti o se, al contrario, tendere la mano all’ala più centrista dell’Elefantino. Uno scenario, quest’ultimo, che lo esporrebbe assai probabilmente però alle critiche delle correnti più a sinistra del Partito Democratico, che non hanno alcuna intenzione di trattare con i repubblicani. Questi ultimi, dal canto loro, hanno già fatto sapere di voler avviare una serie di indagini parlamentari volte a mettere in difficoltà la Casa Bianca: indagini che si concentreranno sulla disastrosa evacuazione afgana dell’anno scorso, sulla crisi migratoria alla frontiera con il Messico, sulle origini del Covid-19 e sugli opachi affari internazionali del figlio di Biden, Hunter, in Ucraina, Cina e Russia.
 Non solo. Negli scorsi mesi, vari big repubblicani hanno anche ventilato l’ipotesi di avviare un processo di impeachment contro l’attuale presidente americano. Una via che, qualora venisse imboccata, non sarebbe concretamente finalizzata alla destituzione dell’inquilino della Casa Bianca (mancherebbe infatti il fondamentale quorum di due terzi al Senato). No: tale strategia sarebbe verosimilmente volta a paralizzare per alcuni mesi le attività del Congresso, bloccando così l’agenda parlamentare di Biden. Una simile situazione rischierebbe di aggravare la già non irrilevante impopolarità dell’attuale presidente americano: un’impopolarità che potrebbe gettare una luce assai negativa su una sua eventuale ricandidatura. Ricordiamo, a tal proposito, che Biden ha reso noto di voler sciogliere le riserve non prima dell’inizio dell’anno prossimo. Tuttavia, anche qualora decidesse di correre per una seconda volta, non è detto che qualcuno – soprattutto a sinistra – non possa cercare di contestargli la nomination (sulla scia della sfida che, nel 1980, Ted Kennedy lanciò a Jimmy Carter).
Non solo. Negli scorsi mesi, vari big repubblicani hanno anche ventilato l’ipotesi di avviare un processo di impeachment contro l’attuale presidente americano. Una via che, qualora venisse imboccata, non sarebbe concretamente finalizzata alla destituzione dell’inquilino della Casa Bianca (mancherebbe infatti il fondamentale quorum di due terzi al Senato). No: tale strategia sarebbe verosimilmente volta a paralizzare per alcuni mesi le attività del Congresso, bloccando così l’agenda parlamentare di Biden. Una simile situazione rischierebbe di aggravare la già non irrilevante impopolarità dell’attuale presidente americano: un’impopolarità che potrebbe gettare una luce assai negativa su una sua eventuale ricandidatura. Ricordiamo, a tal proposito, che Biden ha reso noto di voler sciogliere le riserve non prima dell’inizio dell’anno prossimo. Tuttavia, anche qualora decidesse di correre per una seconda volta, non è detto che qualcuno – soprattutto a sinistra – non possa cercare di contestargli la nomination (sulla scia della sfida che, nel 1980, Ted Kennedy lanciò a Jimmy Carter).
Sul fronte opposto, anche Donald Trump ha i suoi problemi. Nonostante si sia ufficialmente candidato alla Casa Bianca lo scorso 15 novembre, l’ex presidente è uscito notevolmente azzoppato dalle ultime Midterm. In particolare, a indebolirlo sono state le sconfitte dei candidati trumpisti al Senato in due aree strategiche come la Pennsylvania e il Nevada. Ampi settori del mondo conservatore statunitense stanno incolpando proprio Trump dei risultati deludenti ottenuti dal Partito Repubblicano l’8 novembre. Non a caso, vari big dell’Elefantino stanno ufficiosamente scaldando i motori in vista delle primarie presidenziali del 2024.
 Al momento, il nome più forte è quello di Ron DeSantis: quest’ultimo è stato appena trionfalmente rieletto governatore della Florida ed è una figura particolarmente popolare tra la base repubblicana. Un altro nome da monitorare è poi quello del governatore della Virginia, Glenn Youngkin: meno carismatico di DeSantis, può tuttavia vantare discrete doti di federatore (una qualità tutt’altro che trascurabile in un contesto politico balcanizzato come quello statunitense). Ulteriori esponenti repubblicani che potrebbero presto scendere in campo sono inoltre l’ex segretario di Stato, Mike Pompeo, l’ex ambasciatrice all’Onu, Nikki Haley, e l’ex vicepresidente, Mike Pence.
Al momento, il nome più forte è quello di Ron DeSantis: quest’ultimo è stato appena trionfalmente rieletto governatore della Florida ed è una figura particolarmente popolare tra la base repubblicana. Un altro nome da monitorare è poi quello del governatore della Virginia, Glenn Youngkin: meno carismatico di DeSantis, può tuttavia vantare discrete doti di federatore (una qualità tutt’altro che trascurabile in un contesto politico balcanizzato come quello statunitense). Ulteriori esponenti repubblicani che potrebbero presto scendere in campo sono inoltre l’ex segretario di Stato, Mike Pompeo, l’ex ambasciatrice all’Onu, Nikki Haley, e l’ex vicepresidente, Mike Pence.
L’aspetto interessante da rilevare è che, contrariamente a quanto avviene nel Partito Democratico, lo scontro interno ai repubblicani non è di natura politico-ideologica, ma generazionale. Il trumpismo, inteso come maggiore attenzione alle classi lavoratrici e alle minoranze etniche, è stato infatti ormai incamerato da gran parte della struttura dell’Elefantino. Gli stessi papabili candidati presidenziali che abbiamo citato sono trumpisti (come DeSantis) o comunque ex esponenti dell’amministrazione Trump (come Pompeo, la Haley e Pence). Il nodo qui non è quindi tanto l’agenda politica, ma chi deve portarla avanti. La leadership dell’ex presidente sembra essersi appannata e, qualora non riuscisse a rilanciarsi nei prossimi mesi, le nuove leve cercheranno prevedibilmente di far sentire la propria voce. Le elezioni presidenziali del 2024 sono quasi alle porte. E in entrambi i campi regna l’incertezza.