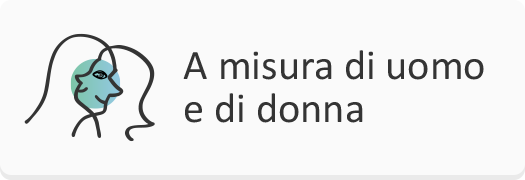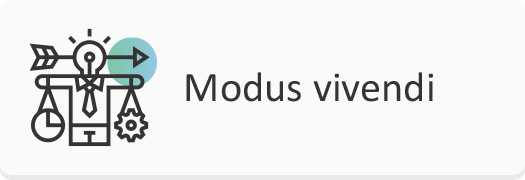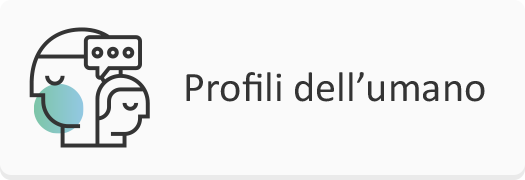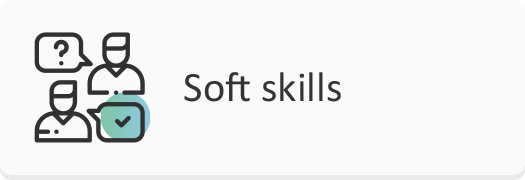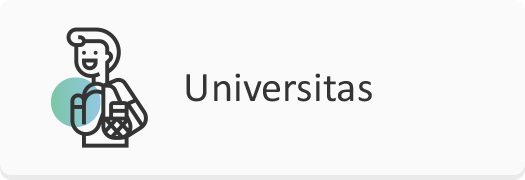di Stefano Graziosi

E’ dai tempi del secondo Dopoguerra che gli Stati Uniti hanno connesso sempre più la dimensione geopolitica con quella economica: dal 1945, Washington – sul fronte internazionale – ha infatti cercato di combinare l’espansione della propria influenza politico-militare con l’ampliamento del sistema economico liberista. Una strategia che, pur con modalità differenti, pressoché tutti i presidenti americani hanno portato avanti: una strategia, dettata – durante la Guerra Fredda – dal serrato confronto geopolitico, ideologico ed economico con l’Unione Sovietica. Questo poi non significa che tale linea sia mutata dopo il crollo del Muro di Berlino. Nel corso degli anni ’90, l’allora presidente democratico, Bill Clinton, incrementò i legami commerciali internazionali, aumentando in questo modo l’interdipendenza politico-economica tra gli Stati Uniti e il resto del mondo e determinando l’intensificarsi del processo di globalizzazione. Un processo nato sotto i migliori auspici, che – nelle intenzioni di Washington – avrebbe dovuto mantenere in piedi l’egemonia geopolitica ed economica statunitense nel post Guerra Fredda. Il tutto, puntando su due pilastri fondamentali: la superiorità militare americana e il trionfo del modello capitalistico. Un modello che, dopo la sconfitta del comunismo, sembrava essersi imposto come definitivamente vincente. Tanto che, in quest’ottica Clinton completò il processo di deregulation del settore finanziario, che era stato avviato dal presidente repubblicano Ronald Reagan negli anni ’80.
Sennonché, ad un certo punto i nodi vennero al pettine. E la tempesta esplose nel corso della presidenza del repubblicano George W. Bush. Gli attentati dell’11 settembre del 2001 portarono gli Stati Uniti alle guerre di Afghanistan e Iraq. Due conflitti che, per quanto inizialmente sostenuti dal popolo americano, sarebbero diventati ben presto impopolari. Soprattutto in Iraq, a partire dal 2005 gli Stati Uniti si ritrovarono progressivamente invischiati in un pantano da cui non sembravano più in grado di uscire. Il mito della forza militare americana era stato infranto e – esattamente come ai tempi della guerra in Vietnam – questo stato di cose determinò un’ondata di rabbia e frustrazione nell’elettorato statunitense. Ma non era finita. La crisi finanziaria, esplosa nel 2007, portò al collasso di alcuni considerevoli istituti bancari, innescando di fatto la Grande Recessione, che travolse drammaticamente l’economia americana negli anni successivi. Nel 2008, il Congresso – su proposta dello stesso Bush – intervenne, stanziando circa 700 miliardi di dollari per il salvataggio delle banche. Il modello capitalistico aveva mostrato tutti i suoi limiti, gettando le basi per il diffondersi di idee socialiste tra l’elettorato d’oltreatlantico. Nel giro di pochi anni, insomma, i due pilastri della politica internazionale statunitense (la superiorità militare e l’assoluta bontà del sistema capitalistico) avevano subìto un durissimo colpo.
Questa situazione di profondissima crisi portò, nel 2008, all’elezione di Barack Obama. Contrariamente a quanto spesso si dice, l’allora senatore dell’Illinois non vinse per la sua giovane età o per l’abilità comunicativa. Vinse perché, in campagna elettorale, aveva cercato di dare una risposta a entrambi i principali problemi che gli Stati Uniti stavano riscontrando. Sul fronte militare, propose un progressivo disimpegno americano non solo dall’Iraq ma anche dai più scottanti scenari internazionali, criticando l’interventismo bellico di Bush. Sul piano economico, avanzò l’idea di un deciso intervento dello Stato in economia, imponendo inoltre delle regolamentazioni all’alta finanza. In questo senso, approvò rispettivamente il Recovery Act nel 2009 e il Dodd-Frank Act nel 2010: misure che furono osteggiate dai repubblicani, in quanto tacciate di statalismo. Meno incisivo Obama riuscì ad essere sul piano della politica estera. Nonostante avesse cercato di tenere fede alla sua strategia di disimpegno, non sempre è in realtà riuscito a perseguirla, anche a causa di resistenze interne alla sua stessa amministrazione. Nel 2011, per esempio, si lasciò convincere a intervenire militarmente contro Gheddafi in Libia dall’allora segretario di Stato, Hillary Clinton. Due anni dopo, rifiutò invece di prendere parte a un attacco contro Assad in Siria, caldeggiato dal suo nuovo segretario di Stato, John Kerry. Lascito controverso dell’eredità di Obama risultarono infine i trattati internazionali di libero scambio. Fortemente celebrati ai tempi di Bill Clinton, negli anni successivi erano finiti al centro di forti polemiche, in quanto accusati di favorire la delocalizzazione della produzione industriale americana con conseguenze disastrose per i posti di lavoro statunitensi. Obama, nel 2016, aveva siglato la Trans Pacific Partnership: un’intesa commerciale tra Washington e altri undici Paesi del Pacifico. Un accordo che, nel corso della campagna elettorale per le ultime presidenziali, venne criticato da più parti.

La proposta elettorale di Trump
E’ in questo contesto tumultuoso che si svolse il duello presidenziale del 2016. Da una parte, la candidata democratica Hillary Clinton proponeva un ritorno al passato: sul fronte internazionale, voleva abbandonare la politica di disimpegno, assumendo di contro una postura aggressiva verso i tradizionali avversari degli Stati Uniti (seguendo, in questo, le linee tracciate da suo marito Bill e dallo stesso George W. Bush). Sul fronte economico poi, Hillary proponeva tendenzialmente una difesa dei trattati internazionali di libero scambio e dei princìpi della globalizzazione.
L’esatto contrario sosteneva Trump. Il magnate newyorchese aveva debellato sedici rivali alle primarie repubblicane, cavalcando una linea antisistema e profondamente avversa al professionismo politico. Nel duello con Hillary, si concentrò quindi su due punti principali. In primo luogo, annunciò che – da presidente – avrebbe rinegoziato i trattati internazionali di libero scambio, siglati dagli Stati Uniti. In secondo luogo, sul fronte geopolitico, dichiarò di voler perseguire una politica estera di disimpegno (volta a contenere i costi umani ed economici), cui congiungere conseguentemente una distensione nei confronti di alcuni degli storici nemici degli Stati Uniti (a partire dalla Russia). Come si può vedere, si trattava di una linea non poi così distante da quella di Obama. L’obiettivo del miliardario era d’altronde quello di farsi portavoce soprattutto della classe operaia impoverita della Rust Belt: una quota elettorale, storicamente vicina al Partito Democratico, ma sempre più furente a causa della globalizzazione e della concorrenza commerciale (giudicata sleale) di Cina e Germania. Alla fine, proprio quella quota dirimente si spostò a favore di Trump (come testimoniato dalla sua vittoria negli Stati di Ohio e Michigan).
E’ del resto in quest’ottica che veniva ad inserirsi la celebre proposta del muro al confine con il Messico. Nonostante molti commentatori abbiano derubricato questa idea a becero razzismo, la realtà appare molto più complessa. La linea dura invocata (e poi attuata) da Trump contro
l’immigrazione clandestina si basa infatti su due obiettivi: uno securitario e uno socio-economico. Il primo (giustificato con il contrasto alla criminalità e ai flussi di droga) era già stato perseguito da Bill Clinton, George W. Bush e dallo stesso Barack Obama. Il secondo è invece più specificamente trumpiano, in quanto il magnate ha progressivamente colto i timori delle fasce sociali indebolite americane (dagli operai alla classe media) nei confronti della concorrenza salariale al ribasso che l’immigrazione clandestina inevitabilmente comporta.
Del resto, il magnate newyorchese riuscì a conquistare la Casa Bianca raccogliendo una coalizione elettorale non poco eterogenea. Una coalizione, cioè, che ha messo insieme mondi politicamente molto distanti tra loro: dagli operai ex democratici della Rust Belt agli evangelici storicamente repubblicani, passando per le classi agricole. Senza dimenticare la maggioranza dei cattolici bianchi, oltre a un elevato numero di elettori indipendenti. Inoltre, sul fronte delle minoranze etniche, Trump è riuscito ad ottenere risultati lievemente migliori di quelli conseguiti dal candidato repubblicano alla Casa Bianca del 2012, Mitt Romney. Alla luce di tutto questo, è dunque chiaro che il magnate newyorchese non potesse (e non possa) essere considerato un repubblicano ortodosso ma che – di contro – su alcune questioni appaia paradossalmente molto più vicino alla sinistra che al conservatorismo statunitense.
Sotto questo aspetto, più di che un fenomeno nuovo e frutto dei social network, Trump sorge da una tradizione politica piuttosto antica negli Stati Uniti, quella dei jacksoniani. Con questo nome erano originariamente designati i seguaci del presidente democratico Andrew Jackson (1828-1836), mentre oggi vi si identifica una categoria culturale ed elettorale minoritaria ma corposa, oltre che tendenzialmente trasversale ai due principali partiti americani. Tra le sue caratteristiche principali si ravvisano: nazionalismo, avversione alle élites, una certa diffidenza verso i ceti intellettuali, richiesta di energiche misure in materia di sicurezza, difesa della libertà individuale e – al contempo – forte senso di comunità.
In che cosa Trump differisce dai repubblicani
Indubbiamente uno dei punti di maggiore attrito con il Partito Repubblicano risiede nella politica commerciale. Storicamente i repubblicani sono fautori del libero scambio e non gradiscono troppo i dazi recentemente imposti dalla Casa Bianca. Trump, dal canto suo, non è un protezionista ideologico ma considera le tariffe come uno strumento necessario per costringere eventuali partner commerciali a comportarsi secondo regole condivise. In questo senso, il magnate ha sempre sostenuto di voler sostituire il “commercio libero” con il “commercio equo”. La guerra tariffaria in corso con la Cina nasce del resto dal tentativo di dare una risposta chiara alle richieste della classe operaia della Rust Belt che – lo dicevamo – considera Pechino e Berlino tra le cause dei propri problemi economico-sociali. Un ulteriore elemento di attrito con i repubblicani riguarda poi la politica monetaria della Federal Reserve. Se i primi sono storicamente fautori di una politica restrittiva, volta a contenere l’inflazione, il secondo auspicherebbe una politica espansiva, che indebolisca il dollaro, favorendo così le esportazioni statunitensi: un fattore che, tra l’altro, desidererebbe utilizzare proprio in chiave anti-cinese. Anche sul versante infrastrutturale, poi, si registrano ampie differenze di vedute. Trump vorrebbe approvare una riforma da 2.000 miliardi di dollari (in gran parte sotto forma di investimenti pubblici): una linea che i repubblicani ortodossi tacciano tuttavia di inaccettabile statalismo.
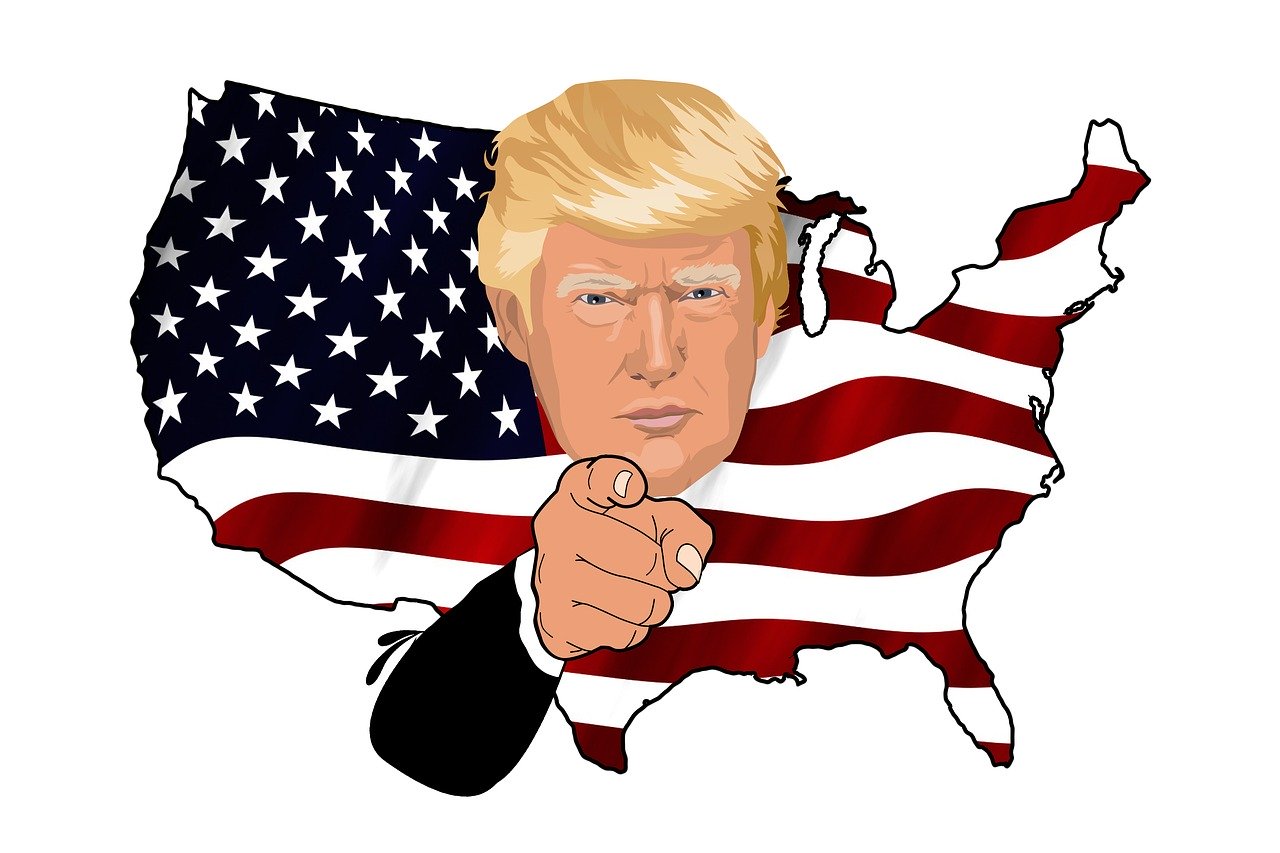
La politica estera risulta, infine, uno degli ambiti di maggior rottura con l’impostazione repubblicana degli ultimi quarant’anni. Dai tempi di Reagan, i repubblicani hanno spesso sostenuto che gli Stati Uniti debbano proporsi come obiettivo la diffusione dei valori democratici e liberali a livello internazionale: George W. Bush (smentendo la linea che aveva avanzato durante la campagna elettorale del 2000) parlò in tal senso della necessità di “esportare la democrazia”. Trump, di contro, ha sinora fatto della sovranità nazionale il perno della propria impostazione. L’idea dell’attuale presidente è che gli Stati Uniti non debbano svolgere alcuna missione messianica né imporre i propri princìpi in giro per il mondo. Elementi chiave della sua linea, sotto questo aspetto, sono costituiti dalla difesa e dal rispetto della sovranità nazionale: fattori che, nell’ottica del presidente, dovrebbero rappresentare la base per instaurare un pragmatico processo di dialogo con gli altri Paesi (soprattutto con i vecchi nemici degli Stati Uniti). In tal senso, si capisce come il concetto di America First non svolga un ruolo soltanto in termini di politica interna ma anche in termini di rapporto con le altre nazioni.
Tutto questo non deve comunque indurre a ritenere che – come talvolta viene detto – l’approccio di Trump sia puramente “isolazionista”. Il presidente non trascura le dinamiche globali ma cerca semmai di alleggerire il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nello scacchiere internazionale, aumentando di riflesso la responsabilità degli alleati regionali. In questo senso, Trump (non troppo differentemente da Obama) sta chiedendo da due anni un maggiore contributo economico della Germania alle spese della NATO. E, sempre in quest’ottica, il presidente sta cercando (non senza difficoltà) di avviare un processo di distensione con la Russia. L’obiettivo di Trump è infatti quello di sganciare innanzitutto Mosca dall’orbita cinese e assicurarsi quindi un partner geopolitico in grado di garantire una maggiore stabilità nel complicato scacchiere mediorientale (dove l’influenza del Cremlino risulta molto forte soprattutto in aree come l’Iran e la Siria).
Le convergenze tra Trump e i repubblicani
Quanto abbiamo visto non comporta tuttavia che non vi siano convergenze tra Trump e il Partito Repubblicano. Il punto di maggiore consonanza riguarda senza dubbio la politica fiscale dell’attuale presidente, che si è concretizzata nel radicale taglio delle tasse approvato dal Congresso nel 2017. Molto interessanti risultano poi i rapporti di Trump con la destra evangelica. Inizialmente quest’ultima non nutriva troppa simpatia per il magnate newyorchese, che era pluridivorziato e con un passato tendenzialmente filo-abortista. Con il passare del tempo, Trump è tuttavia riuscito a conquistarsi questa quota elettorale. E lo ha fatto, seguendo una strategia ben precisa. Non solo ha abbracciato la battaglia anti-abortista ma ha anche nominato un elevato numero di giudici conservatori alla Corte Suprema e alle corti inferiori. Inoltre, il presidente si è intestato la difesa del Primo Emendamento (che tutela la libertà religiosa), nella battaglia del mondo conservatore americano contro le galassie progressiste. Fondamentale nel mantenimento dei buoni rapporti con gli evangelici risulta poi il vicepresidente, Mike Pence: una figura storicamente vicina a quell’aria e che fu scelta proprio garantire a Trump il sostegno della destra religiosa.