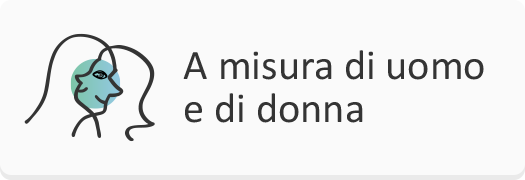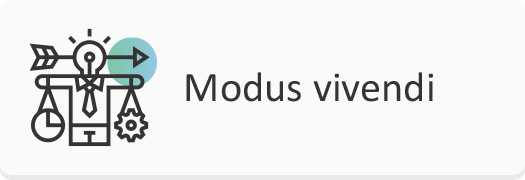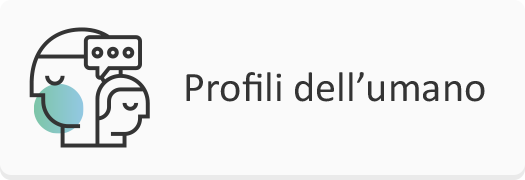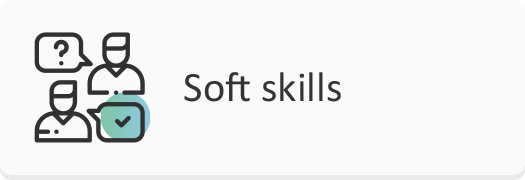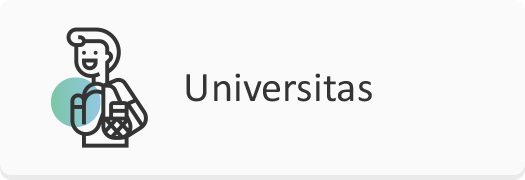di Antonio Petagine

Tra le linee di riflessione proposte da alcuni autori di riferimento, che hanno analizzato i movimenti profondi che animano la società contemporanea, spicca l’idea che stiamo assistendo, ormai da decenni, ad un imponente fenomeno di «individualizzazione». Con questa espressione si intende dire che vi è ormai una consolidata tendenza ad inquadrare la propria realizzazione personale in un orizzonte di tipo quasi esclusivamente «privato»: affidiamo ormai in maniera spontanea le nostre aspettative di felicità principalmente ai traguardi che taglieremo nella nostra carriera, alla qualità del nostro inserimento nella cerchia di persone che ci interessano, all’intensità delle nostre relazioni amorose, alla cura del nostro benessere.
Questo significa allora che viviamo in una società di inguaribili egoisti? Farei attenzione alle parole e ai concetti da usare: l’egoismo è già una tipologia morale, propria di chi rifiuta personalmente di pensare a qualcosa o a qualcuno, che non sia se stesso. Quella che qui viene chiamata «individualizzazione» è un fenomeno diverso: non è l’atteggiamento sbagliato di qualcuno, che potrebbe decidere quindi di comportarsi in un modo diverso e non lo fa. Si tratta piuttosto di una dinamica sociale, di cui vale la pena diventare consapevoli, per comprendere l’impatto che essa esercita su tutti noi, influenzando «sotto pelle» le nostre esistenze e i nostri progetti di vita.
La ragionevolezza di pensare innanzitutto a se stessi
In un libro di successo, un docente universitario come Allan Bloom scriveva alla fine degli Ottanta che i suoi studenti apparivano preoccupati solo di se stessi e di quanto accadeva loro; questo non perché fossero meschini o malvagi, ma perché, più semplicemente, non era stato consegnato loro nessun altro orizzonte in cui inquadrare la propria vita (Cfr. A. Bloom, La chiusura della mente americana. I misfatti dell’istruzione contemporanea, tr. it. P. Pieraccini, Lindau, Torino 2009, pp. 92-96). Bloom mostrava insomma che non fa (o non fa più) parte del nostro patrimonio comune l’idea che la riuscita personale stia in qualcosa che sì, ci coinvolga personalmente, ma allo stesso tempo ci trascenda, come ad esempio la possibilità di contribuire alla costruzione del destino concreto di una comunità, al progresso della scienza, al bene della patria, della Chiesa o anche della famiglia, intesa non solo come luogo «privato» di affetti e interessi, bensì anche come corpo di persone indissolubilmente legate tra loro, che si distende attraverso le generazioni e che si dilata molto al di là dell’individuo e del suo presente.
Ciò non significa, naturalmente, che quando studiamo o quando riflettiamo sul nostro lavoro non ci capiti mai di pensare anche al contributo che possiamo dare alla società o al progresso umano, né vuol dire che non ci importa assolutamente nulla degli altri. Inoltre, sarebbe sciocco negare che anche oggi possiamo fare valide esperienze di impegno sociale, politico e religioso. Tuttavia, non si può minimizzare il fatto che, all’interno del nostro panorama culturale, si sia creata una fortissima tendenza a concepire, almeno in prima istanza, le nostre realizzazioni su un piano strettamente personale: le mie relazioni e il mio lavoro, la mia salute e i miei viaggi, i miei obiettivi e i miei interessi. In una parola, innanzitutto la mia felicità. Perché questo? Perché nel 1918 ci si riconosceva nel destino della Patria o della famiglia, nel 1968 si lottava per un mondo migliore e nel 2018 si pensa principalmente a se stessi? Che cosa è successo?
Un’epocale opera di destrutturazione e di personalizzazione
Il fenomeno di individualizzazione non si può capire, senza considerare che esso fa il paio con un’epocale operazione di destrutturazione e di deregolamentazione, che ha investito istituzioni, ideali, ruoli, consuetudini consolidate: questa significa che nel corso di questi ultimi decenni, per ragioni che non possiamo approfondire qui, è venuto meno ciò che appariva come un riferimento «rigido» a istituzioni, culture, appartenenze o ideologie. In un momento di crisi delle «grandi narrazioni» della politica, della religione e della cultura, in cui il futuro viene presentato sempre più come una minaccia e sempre meno come un’opportunità, le nostre esistenze sono segnate da un certo disincanto, assumendo il marchio della relatività, della rivedibilità, della «fluidità». In tale quadro, non è che non si facciano progetti, ma siamo spinti a concentrarci su quanto è possibile realizzare adesso, o comunque su un periodo di tempo non troppo dilatato.
La destrutturazione sembra segnare anche le logiche del mercato e del consumo: il prodotto si impone sempre meno come «blocco» standardizzato a cui il cliente deve piegarsi, e sempre più con qualcosa di flessibile, modificabile, reso smart dalla capacità di adattarsi alle più disparate istanze dell’individuo. Rispetto al passato, oggi è sempre di più il cliente, nella sua singolarità di gusti, preferenze e giudizi ad essere attivo, partecipando, in un certo modo, alla stessa messa a punto del prodotto. Per questo, è sempre più importante per il business conoscere in maniera precisa i gusti, i comportamenti, i desideri individuali (pensiamo a quanto sono strategici, in tale contesto, il tracciamento dei consumi individuali, la raccolta dei dati prodotti con la navigazione online, come pure il coinvolgimento continuo degli individui in valutazioni, recensioni, sondaggi, ecc.).
Così, in corrispondenza con questo processo, cambia anche la percezione che l’individuo ha di se stesso e dell’orizzonte in cui inquadra la propria vita e le proprie relazioni. Così, rispetto alla trasmissione/assimilazione di «contenuti», «valori» o «sistemi», conta molto per noi il fatto di avere la libertà di esprimerci e la possibilità di fare esperienze tra loro diverse. I rapporti interpersonali, a loro volta, vengono orientati alla «morbidezza» e alla simmetria: alle relazioni noi chiediamo infatti, innanzitutto, di darci benessere psicologico; perciò, in esse cerchiamo di generare – e ci aspettiamo di ricevere – prossimità, attrattiva, piacevolezza. Per questo, assumono uno spazio sempre maggiore le dinamiche lato sensu seduttive, dove grande investimento viene fatto sulla capacità di suscitare emozioni positive in chi ti sta davanti. Così, perfino chi interpreta ruoli asimmetrici (come i genitori rispetto ai figli, le istituzioni verso i cittadini, i superiori nei confronti dei subalterni) cerca di assumere il profilo meno spigoloso possibile, ostentando invece vicinanza, delicatezza, amicalità, privilegiando la comunicazione alla coercizione.
Questa concentrazione sull’individuo e sulle sue «cose», e dunque la spinta a puntare sulla simmetria e sull’emotività, ha indubbiamente portato ad attribuire grande importanza all’auto-rappresentazione che riusciamo a farci e a dare di noi stessi. Per questa ragione, a partire da un fortunato saggio di Christopher Lasch, la nostra cultura è stata etichettata come narcisistica (C. Lasch, La cultura del narcisismo. Rifugio in un mondo senza cuore, tr. it. M. Bocconcelli, Bompiani, Milano 19993). Quest’idea potrebbe apparire un po’ troppo forte, perché il termine «narcisismo», riecheggiando un racconto molto noto dell’antichità, da Freud in poi è stato associato ad un gravissimo disturbo della personalità. Usando questa espressione, Lasch non intendeva certo dire che viviamo in una società di malati psichiatrici – anche se non va trascurata l’incidenza sempre maggiore di disagi psicologici e di disturbi veri e propri, di tipo mentale – tuttavia riteneva innegabile che la nostra cultura veicolasse una serie di tratti e di comportamenti del tutto simili a quelli che la ricerca psicologica inquadrava descrivendo i soggetti narcisisti: il forte ripiegamento su se stessi, la difficoltà nel mettersi nei panni degli altri, l’attenzione eccessiva alla propria salute, il terrore per la vecchiaia e per la morte. Il tratto più peculiare della cultura «narcisistica» sta certamente, secondo Lasch, nel fatto che siamo sempre più spinti a costruire un’immagine del sé e della nostra realizzazione personale così forte ed incidente, che tende a diventare questa la chiave della realtà che viviamo, più che il confronto stesso con la realtà, in carne ed ossa. E se pensiamo che queste riflessioni risalgono al 1979 e riguardavano un uso sempre più privato della fotografia, possiamo immaginare quanto sorprendentemente profetiche possano apparirci oggi, nell’era di Instagram.

Eco e Narciso di Nicolas Poussin (1629-1630)
La messa in atto di questo complesso processo di individualizzazione dovrebbe suscitare in noi un interrogativo tutt’altro che ingenuo: se ci pensiamo bene, il modo migliore per raggiungere un obiettivo è solitamente quello di impegnarsi nel suo perseguimento, con tenacia e convinzione. Così, ad esempio, ci aspettiamo che chi ha dedicato molto tempo ed energie ad imparare una lingua, la parli effettivamente meglio di chi non ha perseguito con tenacia un tale scopo. Eppure, il filosofo inglese John Stuart Mill, nella seconda metà del XIX secolo, enunciava un vero e proprio «paradosso della felicità»: «Sono felici, credo, solo quelli che hanno il loro pensiero fissato su oggetti diversi dalla propria felicità, – sulla felicità degli altri sul progresso dell’umanità, quanto in un’arte una ricerca–, perseguendoli non come mezzo, ma come ideale fine a se stesso. Mirando così a qualcos’altro, essi trovano la felicità sul loro cammino. […] Chiedetevi se siete felici e cesserete subito di esserlo» (J. Stuart Mill, Autobiografia, II, tr. it. D. Pettoello, Carabba, Lanciano 1919, p. 14.).
L’individualizzazione sembra incarnare in maniera chirurgica il paradosso di Mill: se vi è una sorta di imperativo morale, politico e culturale, su cui la nostra cultura si fonda, questo consiste proprio nel mettere a disposizione degli individui gli strumenti migliori per la ricerca della propria felicità, facendola percepire come «a portata di mano». Eppure, proprio questa cultura si trova a veicolare facili percezioni di vuoto e di fallimento, sia a livello personale, che professionale; l’interesse per la qualità della propria condizione psicologica e fisica si trasforma facilmente in ossessività verso la salute, in terrore per l’imperfezione fisica e per la vecchiaia. E che dire della vera e propria filiera di fallimenti affettivi, che portano impoverimento economico e solitudine?
Il punto cruciale è che il processo di individualizzazione spinge l’Io a incentrare tutto l’orizzonte di senso su se stessi e sui propri obiettivi, e lo fa offrendogli un piano de-regolato, debole e fluido di punti di riferimento – siano essi sociali, affettivi o valoriali. Così, l’individuo viene caricato di un compito tutt’altro che banale: la «promessa» che l’individuo possa auto-realizzarsi scivola sottilmente nell’idea che debba farlo. Questo significa però mettersi di fronte alla vita – con le sue gioie, certo, ma anche con le sue difficoltà, i suoi imprevisti e con il suo severo «principio di realtà» – adottando un atteggiamento molto pericoloso, che porta l’Io a rimanere facilmente schiacciato dalle sfide della vita adulta. Scrive con grande efficacia Lipovetsky: «É possibile che una società che impone a ognuno di essere se stesso domandi troppo agli individui, ma, soprattutto, fa sì che questi, attraverso la cultura del benessere totale, siano spogliati delle risorse psichiche, delle difese interiori per far fronte ai rischi e alla nuova complessità dell’esistenza e siano poco, o male, preparati a subire i colpi della sorte […]. Oscillando continuamente tra ottimismo e pessimismo, depressione ed eccitazione, abbattimento ed euforia, senso di vuoto e progetto costruttivo, il morale dell’individuo ipermoderno è uno yo-yo» (G. Lipovetsky, La felicità paradossale. Sulla società dell’iperconsumo, Cortina, Milano 2007, pp. 167-168).
Affondare nelle radici dell’Io
Diventare consapevoli di questa spinta individualizzatrice che caratterizza la nostra società costituisce certamente uno stimolo a misurarsi con franchezza con il modo in cui interpretiamo il senso più profondo delle nostre vite. Il punto più delicato riguarda infatti la promessa di felicità che l’individualizzazione veicola. Ebbene, alla base della nostra ricerca della felicità non sta infatti semplicemente il riempimento delle nostre attese di soddisfazione, ma anche – e forse soprattutto – la consapevolezza di dedicare il nostro tempo e le nostre energie alla realizzazione di qualcosa che abbia senso e valore; qualcosa a cui valga la pena orientare i nostri talenti e il meglio di noi stessi; qualcosa che ci faccia diventare un certo tipo di persona, in cui ci possiamo riconoscere.
In tal senso, prendere atto del processo di individualizzazione rappresenta un’interessantissima sfida: proprio le dinamiche tipiche della società contemporanea, con le sue luci – chi tornerebbe infatti indietro, oggi, rispetto a certe maniere «spicce» con cui veniva gestita l’autorità di genitori o insegnanti, o rispetto a certe retoriche novecentesche sulla patria, sulla politica o sulla religione? – e con le sue ombre, ci permettono di osservare, come per contrasto, ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Si tratta senz’altro di mettere al centro l’individuo, la persona, i suoi talenti, ma questo risulta impossibile se l’individuo si concepisce come un microcosmo sfittico, tutto impegnato nella costruzione della propria gabbia dorata dell’auto-rappresentazione. Abbiamo bisogno di relazioni di valore e di destinazioni credibili, che possono essere costruite solo andando in profondità, fino alle radici più genuine dell’Io e delle sue ragioni più intime. In tal senso, il «disagio della modernità» ci dà un messaggio molto chiaro, che vale la pena mettere bene a fuoco: «per la maggior parte di noi, le più grandi felicità e infelicità non sono tanto condizionate dall’acquisizione delle cose, ma, piuttosto, dal rapporto con se stessi e con il prossimo» (Lipovetsky, Una felicità paradossale, p. 152).